Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.
Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.
Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.
Seduto all’estremità della panca, non riesce a dissimulare una certa inquietudine. Indossa una giacca di tweed, calzoni grigi, e in generale si distingue per un aspetto e un tono molto professionali. Intreccia le mani, si torce le dita, si tocca i capelli, i folti baffi neri, si stropiccia gli occhi e con la destra sfiora il fermaglio della cravatta. Infine, si decide a guardare dritto negli occhi il presidente della Corte. Quando Antonino Cusumano – il “demiurgo” chiamato, per dovere istituzionale, a scavare nei meandri di non troppo lontani, terribili, ricordi – lo chiama, lui, distinto ed elegante, fa pochi passi in avanti e si accomoda di fronte al microfono. La platea attorno assiste silenziosa, come per tutte le udienze più importanti di questo processo.
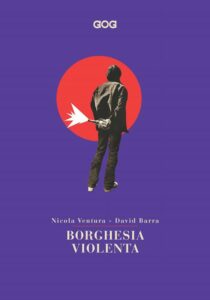
Il presente passo è tratto dal nostro «Borghesia violenta» (Gog edizioni, 2021)
Luigi Montinari, medico dentista quarantenne, sta per essere ascoltato dalla Corte d’assise che si occupa del caso Ramelli. Anche a lui si chiedono stralci di verità, attraverso la rievocazione di anni roventi, di un agguato e di una morte. Quello di Montinari non è un interrogatorio traumatico: alle domande poste dal presidente con cautela, senza inutili protagonismi, il medico risponde con voce ferma e proprietà di linguaggio, esponendo ricordi che non sembrano essere troppo offuscati. In lui sopravvive ancora qualche rara reminiscenza del lessico di una sinistra di un’altra epoca. «No, oggi non farei più niente contro un mio simile», dice, «ma ora è difficile discutere le scelte di dodici anni fa».
Sono passati pochi minuti, ma ormai il ghiaccio è rotto. Con la mente e le parole il medico torna indietro ai cosiddetti “anni delle spranghe”, in particolare a quel 1975, nel quale, oltre a prendere la laurea, partecipa assieme ad altri suoi compagni di Avanguardia Operaia all’aggressione contro Ramelli. Conscio del proprio ruolo di copertura all’interno del commando assassino, Luigi Montinari in aula si comporta tutto sommato con dignità, evitando di cercare troppe giustificazioni al comportamento suo e dei compagni.
L’origine della propria militanza politica viene descritta in pochi tratti: «Nel 1971 mio padre gestiva un bar a Città Studi, in piazza Ascoli, dove veniva gente di Lotta Continua, Movimento Studentesco, Avanguardia Operaia e altri gruppi. Un po’ alla volta mi avvicinai proprio ad Ao, prima nella struttura dei comitati di base, poi dentro l’organizzazione. A spingermi verso la politica era stata una forte carica emotiva dovuta da una parte alla situazione internazionale, dall’altra alla nostra esperienza personale dentro l’università. C’era stata piazza Fontana, la strategia dello stragismo, che ci portò a considerare centrale l’impegno antifascista».
Un giorno del 1973, Montinari incappa in una squadra di neofascisti che stanno tornando dalla manifestazione nella quale era stato ucciso l’agente Marino: «Ho fatto appena in tempo a rientrare in macchina che mi hanno sfasciato i finestrini a sassate. Questo episodio mi ha convinto a entrare nel servizio d’ordine». In che cosa consistesse questo antifascismo, a parte le botte per le strade, Montinari non è però in grado di spiegarlo. «Il nostro, e il mio in particolare, era un impegno antifascista. Il compito che ci prefiggevamo non era soltanto quello di dare la caccia al fascista, ma di far chiarezza su molte cose, tra cui il problema della casa. C’era poi la volontà di bloccare la spirale dello stragismo dopo piazza Fontana a Milano e piazza della Loggia a Brescia». Perché proprio Ramelli? «Non è facile a dirsi. Per me era un ragazzo del Fronte della Gioventù e come tale un avversario politico, anche se non lo conoscevo personalmente. Non sapevo nemmeno chi fosse».
Primi di marzo. «C’è una riunione di cellula», racconta Montinari, «piomba Grassi e dice che dobbiamo essere disponibili il 13 marzo per un’azione. Lo dice senza spiegare meglio le ragioni. Era un periodo importante per i miei studi. Ero un po’ indietro con gli esami. Dovevo darci dentro per laurearmi ed evitare che mio padre avesse da ridire, ma comunque il 13 mi allontanai dalle lezioni di pediatria, che seguivo all’ospedale di Vialba, per raggiungere il luogo dell’appuntamento: l’auletta di Biologia a Medicina. Arrivai in ritardo e ci trovai solo Grassi. Mi disse di sbrigarmi, che gli altri si erano già avviati, e mi diede una chiave inglese. No, forse un tondino. Presi l’oggetto, lo misi tra il pullover e il paltò e mi affrettai fuori dall’università. Raggiunsi gli altri. Qualcuno mi spiegò cosa fare. In via Amadeo si infilarono Marco Costa e Giuseppe Ferrari Bravo. Il mio compito e quello di altri era di proteggerli. Siamo stati lì dieci minuti, un quarto d’ora. Ramelli non l’ho proprio visto. Guardammo le vetrine. A un certo punto vedemmo Costa e Ferrari Bravo uscire dalla via di corsa e capimmo che era il momento di andarcene. Era l’inizio della ritirata, scappammo via tutti. Ci ritrovammo poi nell’auletta. Restituii la chiave inglese. Tornai a casa e non parlai con nessuno. Il giorno dopo, quando aprii il giornale in cerca del trafiletto su un giovane neofascista colpito, scoprii che invece quel ragazzo era in coma. Corsi all’università, trovai Grassi e gli proposi di sciogliere subito la squadra di Medicina. Ero spaventato, preoccupato e Roberto mi disse di aspettare, mi disse che non sarebbe successo niente. Noi avevamo previsto una lezione, un pestaggio. Usando un gergo medico, l’aggressione avrebbe dovuto determinare una prognosi di qualche giorno».
Invece Ramelli viene raccolto con la testa fracassata. Morirà dopo oltre quaranta giorni di agonia. Quando il pubblico ministero Maria Luisa D’Ameno domanda a Montinari, ancora una volta, il perché di quella aggressione, si sente rispondere che l’azione aveva come obiettivo quello di interdire e rendere inagibili determinati spazi ai fascisti: «Nessuno di noi, per esempio, osava mettere piede in piazza San Babila», dice Montinari, quasi a voler rendere più chiaro il concetto. L’azione punitiva, l’agguato omicida, insomma, assume ancora una volta una valenza astratta, un qualcosa da fare per dovere ideologico e che proprio per questo ha a che vedere con un processo, un tentativo, di rimozione. «Avevamo vergogna, lo ripeterò sempre. Non è un atteggiamento strumentale per il processo. Ho una totale mancanza di ricordi. Ho continuato per qualche mese a militare in Avanguardia Operaia, defilandomi a mano a mano dal servizio d’ordine. Con gli altri ci siamo riuniti un paio di volte, poi basta. In seguito ho incontrato Costa, per caso. “Come stai?”, gli ho chiesto. Il riferimento era tacito, non c’era bisogno di parole. “Malissimo”, mi ha risposto. E non c’era bisogno di capire perché».
Il presidente Cusumano, incredulo, osserva ancora una volta: «Le chiavi inglesi potevano smontare un transatlantico. Bastava ne cadesse una per arrecare un danno enorme. Voi, poi, eravate studenti di Medicina…». La risposta di Montinari viene pronunciata con una voce ormai stanca: «Non avere valutato le conseguenze dell’impatto fisico, fu il nostro errore. Di chiavi inglesi non avevamo esperienza».