Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.
Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.
Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.
Alcuni luoghi, per la loro posizione strategica, diventano punti nevralgici nello scacchiere geopolitico globale. In un mondo interconnesso, il controllo delle rotte commerciali determina il peso politico di intere nazioni. Cipro incarna perfettamente questa dinamica: isola incastonata nel Mediterraneo orientale, ha attraversato secoli di contese divenendo simbolo delle tensioni tra Grecia e Turchia oggi cristallizzate nella divisione tra comunità turco-cipriota e greco-cipriota.
A influenzare il destino di Cipro, però, non sono state soltanto le rivalità regionali. Sullo sfondo si staglia la persistente ombra britannica: il Regno Unito, come retaggio del suo passato coloniale, mantiene sull’isola due basi militari, nodi strategici per il controllo del Mediterraneo orientale.
In mezzo a rivolte, accordi e conflitti, una costante attraversa la storia di Cipro. La presenza di Londra.
L’Impero Ottomano di fine Ottocento era un soggetto politico in affanno. Attaccato dalla Russia nel 1878, il sultano Abdulhamid II fu salvato dall’intervento britannico. La diplomazia di Sua Maestà intervenne per mettere un freno all’espansionismo russo. La stabilità ottomana fu, quindi, garantita da Londra. L’intervento, tuttavia, non era disinteressato. Cipro venne occupata e amministrata dagli inglesi rimanendo solo formalmente parte dell’Impero Ottomano per una serie di ragioni ben spiegate da un passo del libro Cyprus, its past, present and future, inserito in un articolo uscito il 15 settembre 1922 sulla rivista Oriente Moderno:
«Poche parole basteranno per illustrare i vantaggi che l’Inghilterra attende dal possesso di Cipro. Essa costituisce un avamposto estremamente utile per la difesa del canale di Suez; essa proteggerà i trasporti, in Asia, di una futura linea ferroviaria nella Valle dell’Eufrate; sarà il punto di partenza di tutte le operazioni che diverranno forse necessarie, in avvenire, nella Turchia asiatica. Tutte le grandi dinastie conquistatrici, — quelle di Assiria, di Babilonia, di Persia, di Macedonia — prima di toccare l’Egitto hanno considerato come necessario il possesso dell’isola di Cipro. Noi abbiamo dunque ogni ragione di essere soddisfatti che questa importante posizione sia oggi in nostro potere. Essa è per noi preziosa sotto tutti i riguardi; è una vera barriera che noi opporremmo, presentandosene il caso, a qualsiasi Potenza minacciasse le nostre comunicazioni attraverso l’Egitto. Padroni dell’India, e fermamente risoluti a rimanervi a qualunque prezzo, è per noi della massima importanza possedere una via sicura e certa verso i possessi lontani. Ora, con l’occupazione di Cipro, da una parte, e quella di Malta dall’altra, noi siamo sicuri di aver sempre un passaggio libero».
Parole talmente chiare che potrebbero anche non essere commentate. Le direttrici geopolitiche che spingevano Londra a mettere le proprie mani su Cipro nel 1878 sono le stesse che la mantengono sull’isola a quasi 150 anni di distanza dall’offensiva russa contro gli ottomani. Tuttavia, la presenza britannica, per quanto preferibile a quella turca, non era soddisfacente per i patrioti ciprioti, favorevoli all’enosis, cioè all’unione, con la Grecia.
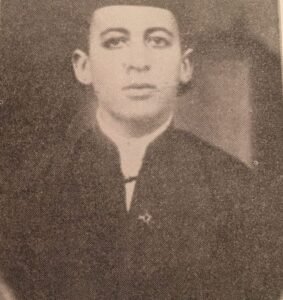
Michaíl Christodulu Mùskos, futuro Makarios III, da giovane (fonte dell’immagine: cyprusexploration.com)
I primi sommovimenti dei ciprioti per chiedere una gestione diretta del governo risalgono al periodo tra il 1911 e il 1913. Proprio in questo lasso di tempo emergeva il ruolo della chiesa autocefala. L’arcivescovo, definito anche etnarca, insieme a due suoi vescovi aveva creato un Comitato centrale con cui veniva coordinata la lotta politica per l’autogoverno. Nel 1913 si arrivò addirittura ad autoproclamare l’unione con la Grecia. L’azione venne fermata dalla presenza britannica e il conflitto sotterraneo fu sedato proprio all’inizio della Prima Guerra Mondiale. Il 5 novembre 1914, infatti, Cipro fu ufficialmente annessa alla Gran Bretagna. Per qualche decennio la situazione rimase tutto sommato sotto controllo.
Negli anni Cinquanta, tuttavia, nacquero diverse organizzazioni guerrigliere come l’EOKA, con l’obiettivo di sancire l’unione con Atene. Non si poteva ignorare, però, la presenza dei turco-ciprioti. I due gruppi etnici erano divisi e avevano ambizioni diverse, parzialmente e precariamente messe insieme nel corso degli accordi di Zurigo e Londra del 1960. Nasceva ufficialmente Cipro, Nazione indipendente sulla carta ma affidata, nei fatti, a un condominio anglo-turco-greco. I tre Paesi avevano obiettivi contrastanti e ciò ebbe un riflesso estremamente concreto nel corso dei decenni successivi. Ma come si era arrivati a questo punto?
Arcivescovo dal 1950 e primo presidente di Cipro dal 1960, Makarios III fu una figura decisiva per la storia dell’isola. Nato da una famiglia di umili origini, Michaíl Christodulu Mùskos, questo il nome secolare dell’arcivescovo, scalò rapidamente le gerarchie della chiesa cipriota. Dopo esserne arrivato al vertice, Makarios divenne il campione dell’indipendenza cipriota oltreché leader influente del Movimento dei Paesi non Allineati. La sua idea sul destino di Cipro, tuttavia, si modificò nel corso del tempo.
Il Makarios politico degli anni Cinquanta aveva due obiettivi principali da ottenere: consolidare il ruolo dei nazionalisti e internazionalizzare la questione cipriota. Per raggiungere le sue finalità, creò un Concilio dell’Etnarca in cui introdusse anche elementi laici come avvocati e giornalisti, e un’Assemblea Nazionale, nata nell’aprile del 1952 per rappresentare le varie componenti sociali dell’isola. Makarios era ben consapevole della necessità di avere un supporto che andasse oltre a quello prettamente religioso. Fu quindi capace di legarsi a gruppi politici di estrazione contadina come l’Unione Panagraria di Cipro (il PEK) e il SEK di Michael Pissas. Si spinse perfino a fondare una federazione giovanile, chiamata Organizzazione giovanile nazionale pancipriota, il PEON.
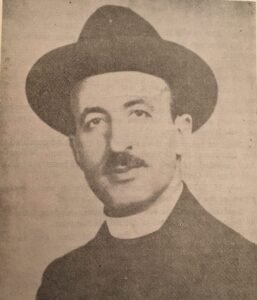
Un’altra immagine di Makarios, risalente probabilmente alla seconda metà degli anni Quaranta, durante il soggiorno per studio negli Usa (fonte dell’immagine: cyprusexploration.com)
Nella metà degli anni Cinquanta, Makarios era sostenitore dell’enosis con la Grecia, fortemente anticomunista e scettico nei confronti della guerriglia portata avanti da Georgios Givras, leader dell’EOKA. I due si incontrarono ripetutamente, ma le loro azioni andavano in direzioni opposte. Makarios si era appoggiato in più di un’occasione ai politici greci con l’obiettivo di far vedere al mondo la condizione in cui versava Cipro. I suoi tentativi, spesso infruttuosi, erano indirizzati anche nei confronti dell’ONU. Dall’altra parte Grivas, che aveva creato un suo comitato di liberazione, insisteva sulla strada della lotta armata. Makarios manteneva un atteggiamento ambiguo da questo punto di vista. Pur essendo contrario all’uso della violenza, l’arcivescovo aveva partecipato alla prima riunione dell’organizzazione di Grivas.
Perseguendo il suo obiettivo di internazionalizzazione Makarios iniziò, proprio negli anni Cinquanta, a creare legami con i leader del mondo arabo, accomunati al cipriota dalla comune lotta anticoloniale contro la Gran Bretagna. Grivas, nell’aprile del 1955, aveva cominciato una dura campagna di atti terroristici che Makarios non condannò. Nello stesso anno, l’etnarca era andato a Bandung, in Indonesia, per la conferenza dei Paesi non Allineati, dove si incontrò anche, tra gli altri, con Nehru, Nasser e Sukarno.
Makarios legò le lotte cipriote a quelle anticoloniali delle altre Nazioni. I toni antibritannici si alzarono:
«L’amicizia anglo-greca è inaccettabile per il popolo greco perché è a senso unico e perché la libertà di Cipro è strangolata in nome di questa amicizia…»
La situazione rimaneva in ebollizione con Makarios e Grivas che si parlavano continuamente. Dopo molta inerzia, intervenne il nuovo primo ministro britannico Eden. Egli preparò un piano per l’autogoverno in cui emergevano, tuttavia, le idee turcofile e per questo non era ben visto da Makarios. I suoi toni erano questi:
«Vi assicuro che i Ciprioti hanno raggiunto la decisione – un’irrevocabile decisione – di liberarsi dal dominio straniero. Non dobbiamo essere preoccupati, non dobbiamo essere intimiditi, non dobbiamo inginocchiarci alle leggi illiberali, all’oppressione, all’imprigionamento, all’esilio e perfino alla morte. Tutto per la libertà! Lunga vita alla libertà!»
Mentre la violenza dell’EOKA proseguiva, Turchia, Grecia e Gran Bretagna si incontrarono ripetutamente senza pervenire a una soluzione che potesse essere ritenuta soddisfacente per tutti. I greco-ciprioti volevano l’enosis mentre i Turchi puntavano alla tutela della propria minoranza presente sull’isola. Tra la fine del 1955 e l’inizio del 1956 la situazione precipitò ulteriormente con la proclamazione dello Stato di emergenza.
In risposta agli avvenimenti ciprioti, Londra decise, nel marzo 1956, di dare l’autorizzazione all’arresto di Makarios, che venne eseguito il 9 marzo 1956 mentre l’arcivescovo stava volando verso Atene. Secondo i britannici, Makarios rappresentava un problema per il ripristino dell’ordine pubblico a Cipro. La mossa piacque soprattutto alla Turchia. Ciò ebbe conseguenze rilevanti e contrarie al ragionamento di Londra. Manifestazioni e proteste si moltiplicarono. Makarios fu mandato, insieme ad altri membri dei vertici della chiesa cipriota, alle Seychelles dove passò il suo tempo tra studio, lavoro ed escursioni. In questo periodo maturò il suo distacco dall’idea dell’enosis con la Grecia. Nel frattempo, a Cipro i britannici sfidavano Grivas e l’EOKA. Londra provò ad avanzare, con Makarios alle Seychelles, l’idea di una costituzione autonomista. L’etnarca fu coinvolto, ma la sua posizione era decisamente scomoda.
Per due anni la situazione sembrò rimanere sospesa tra problemi di ordine pubblico e discussioni sterili. Il 28 marzo 1957 Makarios fu liberato con il divieto di tornare a Cipro. Andò allora ad Atene dove fu accolto come un eroe del nazionalismo greco. Rimaneva la lieve intolleranza dei britannici nei suoi confronti. Egli stava già per abbracciare l’idea dell’indipendenza, mentre i Turchi erano più inclini alla partizione dell’isola. Demograficamente, tuttavia, non c’erano sull’isola zone a maggioranza turco-cipriota. Sempre in questa fase i dissapori tra Grivas e Makarios aumentarono. Nel ginepraio di opinioni e posizioni, la situazione appariva in continua evoluzione. In Grecia la svolta era arrivata con il primo ministro Karamanlis e il suo ministro degli Esteri Averoff. I due ritenevano che l’indipendenza di Cipro fosse la soluzione migliore. Makarios cominciò così ad assecondare gli alleati greci anche perché la sua idea di internazionalizzare la questione cipriota stava naufragando.
Né Usa né Urss, infatti, volevano prendere una posizione chiara. La violenza interetnica stava aumentando, causata dalla nascita del Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), milizia turco-cipriota che si opponeva ai gruppi armati greco-ciprioti favorevoli all’unione con Atene. Un accordo non era più procrastinabile.
Gli accordi di Zurigo per l’indipendenza di Cipro, maturati tra il 5 e l’11 febbraio 1959, furono preceduti da lunghi incontri preliminari, di cui Makarios fu tenuto a conoscenza. Egli diede il suo via libera al Trattato di Alleanza e a quello di Garanzia. I greci, tuttavia, fecero concessioni ulteriori ai turchi, non presentate a Makarios, che si trovò così davanti al fatto compiuto. Dopo enormi indecisioni, dovute proprio a tale gioco diplomatico dei greci, Makarios diede il suo benestare e così Cipro, dopo una certa dose di violenza e lunghe trattative, divenne indipendente.
L’etnarca della chiesa autocefala cipriota fu eletto primo presidente dell’isola indipendente nel 1960. La scelta di rendere la propria Nazione uno dei Paesi non allineati ebbe diverse conseguenze all’interno dell’amministrazione statunitense, guidata da John Fitzgerald Kennedy. Nei report su Makarios, visibili online, si legge:
«Avendo letto il report del Dipartimento (di Stato ndr) sulla situazione di Cipro, sono preoccupato dal suo tono cupo. Le inadeguatezze del governo di Makarios, in contrasto con la disciplina, l’energia e l’abile leadership del locale Partito Comunista, sono molto preoccupanti».
L’obiettivo di Makarios in politica estera era quello di tenere Cipro indipendente mentre dal punto di vista interno voleva superare le divisioni etniche modificando la Costituzione con una serie di emendamenti i quali, tuttavia, trovarono la forte opposizione dei turco-ciprioti. Questi ultimi guardavano con sospetto alle manovre di Makarios, timorosi di diventare cittadini di secondo livello rispetto ai greco-ciprioti.
Dopo l’indipendenza di Cipro, Londra continuò ad avere una certa attenzione nei confronti dell’isola dove si trovavano ancora due basi militari britanniche. Emerse, tuttavia, anche il ruolo della nuova superpotenza di riferimento dell’Occidente, gli Stati Uniti. A Washington, come già evidenziato in precedenza, Makarios non era visto di buon occhio e venne anche definito il «Fidel Castro del Mediterraneo».
La particolare attenzione degli statunitensi fu dovuta a due fattori: in primis l’importanza geopolitica di Cipro e poi il timore che Makarios potesse essere attirato nell’orbita comunista, sospinto anche dalla presenza di un partito comunista cipriota, l’AKEL. Gli Usa volevano avere un ruolo più attivo e ridurre questa «malevola» influenza. Dibattiti su Makarios, dunque, si ripeterono continuamente, di pari passo con la discussione sulle manovre da adottare. Washington, perseguendo nella sua tradizionale tattica, considerava di primaria importanza penetrare economicamente nel tessuto dell’isola per poi poter influire sull’ambiente politico locale. Rimane il fatto che le azioni statunitensi erano in collaborazione continua con la Gran Bretagna, tradizionalmente potenza tutelare di Cipro.
In un documento, si legge così:
«Il Governo Britannico è seriamente preoccupato dalla dichiarazione del 4 gennaio del Presidente Makarios di Cipro che vorrebbe cercare certi emendamenti per la Costituzione di Cipro. Parlando con l’ambasciatore il 5 gennaio, Jamieson del Dipartimento Centrale ha detto che gli sforzi di Makarios in questa direzione non sono solo illegali nei termini basici ma potrebbero anche stimolare la violenza interetnica a Cipro».
Makarios, in realtà, perseguiva un normale progetto di state building con il tentativo di creare un’identità statuale cipriota che superasse la divisione turchi-greci. Compito sicuramente non semplice visto che i turco-ciprioti mantenevano la propria rete di contatti internazionali, dialogando anche con Washington e Londra. Quest’ultima, come si evidenzia nei documenti statunitensi declassificati, cercava di evitare che Makarios proseguisse sulla strada delle modifiche costituzionali. L’etnarca cipriota puntava alla omogeneizzazione delle due etnie e all’industrializzazione del Paese, necessaria per rendere l’isola meno dipendente dall’agricoltura e dagli aiuti esteri.
Makarios, il 5 e 6 giugno 1962, ebbe due distinte conversazioni con Kennedy e altri personaggi importanti dell’amministrazione americana nelle quali ribadì la sua volontà di tenere Cipro all’interno del Movimento dei Paesi non Allineati. In ottica statunitense questi dialoghi erano utili per non far calare l’attenzione nei confronti dell’isola e per combattere l’influenza comunista:
«Due dei progetti di aiuto che stiamo attualmente iniziando a implementare – il programma di addestramento della polizia e il programma sul lavoro – sono creati specificamente per aumentare le capacità cipriote di resistere alla sovversione comunista. Dal punto di vista diplomatico, vogliamo proseguire con i nostri sforzi per persuadere il Presidente Makarios e gli altri leader ciprioti di ricercare politiche anticomuniste più attive… Mentre non possiamo contare su nessun improvviso e radicale irrigidimento nelle politiche di Makarios in questo campo, speriamo che i nostri sforzi abbiano un significante effetto cumulativo nel corso dei prossimi mesi. Ci sono già segnali che il governo cipriota stia progettando supporto per l’ala anticomunista del movimento dei lavoratori».
Nel settembre 1962, Makarios incontrò anche il vicepresidente Usa Lyndon Johnson, sempre in relazione alla crisi degli emendamenti sulla Costituzione cipriota. Negli ultimi mesi del 1963 la situazione rientrò, anche per l’influenza statunitense sulle due comunità. Tuttavia, nel marzo del 1964 l’ONU decise di inviare sull’isola un contingente di caschi blu. Lo scopo era quello di verificare che non riprendessero le violenze interetniche che avevano caratterizzato la prima metà degli anni Sessanta. Per qualche tempo, su Cipro e le sue due comunità regnò la calma.
Il golpe in Grecia nel 1967 fece salire enormemente la tensione sull’isola. Il governo nazionalista aveva come obiettivo l’enosis di Cipro, senza compromessi con la componente turco-cipriota. Poco dopo la salita al potere dei militari ellenici, Istanbul minacciò l’invasione dell’isola per proteggere la propria comunità. Si mosse direttamente il presidente statunitense Lyndon Johnson che, per abbassare i toni, scrisse alle massime autorità turche, greche e cipriote. Questo era il messaggio inviato a Makarios:
«Sua Beatitudine: gli sviluppi su e relativi all’isola di Cipro durante gli ultimi giorni hanno creato una situazione di massima gravità. Per come la vedo, il problema è guerra o pace e non il giusto e lo sbagliato di qualche specifico problema. Mi rivolgo a te, come mi rivolgo al Re Costantino e al Presidente Sunay, per fare tutto ciò che è in potere del vostro governo per ridurre la minaccia alla pace che incombe attualmente sulla vostra regione. In particolare mi sembra che in questa situazione esplosiva il proseguimento dei pattugliamenti nelle zone dell’attuale conflitto è estremamente pericoloso per la pace a Cipro e nel Mediterraneo orientale».
Si cercava un accordo, da costruire con l’impegno di Stati Uniti e Gran Bretagna. Il Dipartimento di Stato consigliava all’ambasciata statunitense a Cipro di fare pressioni su Makarios per concedere vantaggi ai turco-ciprioti. L’incaricato Usa per la questione isolana, Cyrus Vance, riuscì a imbastire un’intesa che evitasse l’intervento turco e quindi la reazione dei greci. Lo scontro tra due Nazioni appartenenti alla Nato avrebbe avuto conseguenze molto complesse da gestire. La paura di questo conflitto spinse Makarios a chiedere la demilitarizzazione dell’isola. Mossa lungimirante dal momento che l’allarme era rientrato, ma una nuova crisi sembrava essere solo questione di tempo.
Nonostante la mediazione di Vance, infatti, la situazione rimaneva difficile. Makarios dovette fronteggiare il ritorno di Grivas sull’isola, giunto «segretamente» a Cipro nel 1971. Le pressioni sul presidente-arcivescovo arrivavano anche da Atene dove la giunta dei colonnelli chiese e ottenne l’esclusione del partito comunista cipriota, l’AKEL, e di un piccolo partito socialista dal governo. Un’altra manovra dei militari ellenici puntava a mettere in difficoltà Makarios all’interno della chiesta cipriota. I greci, infatti, spinsero i vescovi metropoliti di Paphos, Kitium e Kyrenia a chiederne le dimissioni da arcivescovo.
Makarios riuscì a tenere in piedi il proprio sistema di potere grazie all’enorme favore popolare di cui godeva. L’etnarca fermò anche la manovra dei vescovi ribelli, rafforzando la sua struttura di potere all’interno della chiesa cipriota. Ciò non toglie che fosse stato indebolito dai colpi della Giunta militare greca. Il suo fedele ministro degli Esteri, Kyprianou, si dimise dopo undici anni di fedele vicinanza al Presidente. Il rimpasto di governo fu completato tra enormi pressioni da parte della Grecia e della comunità turco-cipriota.
Makarios, da navigato politico, cercò e riuscì a barcamenarsi tra le richieste dei colonnelli e la consapevolezza di dover mantenere margine di manovra. Nel gennaio 1973 venne rieletto presidente con la violenza interetnica che aumentava. Per contrastare la neonata EOKA B di Grivas, creò i suoi gruppi paramilitari che, coadiuvati da una nuova polizia, puntavano a dare stabilità, ma ottennero l’effetto opposto: la tensione continuò a salire. I tentativi di ucciderlo in questa fase furono numerosi, ma l’arcivescovo riuscì sempre a schivare la morte. La Turchia del nuovo presidente Ecevit, inoltre, gettò benzina sul fuoco chiedendo una soluzione federale per Cipro. La morte di Grivas, avvenuta il 27 gennaio 1974, non servì ad allentare la pressione sull’isola. La posizione traballante di Makarios fu ulteriormente peggiorata dalla perdita di controllo sulla Guardia Nazionale, oramai un feudo dell’EOKA B e dei due eredi di Grivas, Sampson e il generale Denisis.
Il regime militare greco era in difficoltà dal punto di vista interno, ma proprio per rafforzare la sua posizione cercò successi all’estero. L’enosis con Cipro sarebbe servita a compattare la popolazione e le forze armate. L’intelligence ellenica, il famigerato KYP, pesantemente finanziato dalla CIA ai suoi albori, mise sotto il proprio diretto controllo l’EOKA B. Nel frattempo un giornale vicino a Makarios svelò la trama di un presunto golpe contro l’etnarca, sventato dai servizi di sicurezza ciprioti. Anche in questo caso, era solo questione di tempo.
Nella giornata del 15 luglio 1974, la Guardia Nazionale entrò in forze a Nicosia. La capitale dell’isola venne messa sotto controllo, prendendo possesso di varie radio mentre i militari circondavano il palazzo presidenziale. Makarios, avvisato di ciò che stava accadendo, riuscì a scappare in maniera rocambolesca requisendo varie automobili ad alcuni comuni cittadini. Alla fine, riuscì a rifugiarsi nel monastero di Kykkos.
A Nicosia, Nikos Sampson si autoproclamò presidente. Makarios fece sentire la sua voce facendo un annuncio alla radio da una piccola stazione:
«Ciprioti! Voi conoscete questa voce. Voi conoscete chi sta parlando… Sono io, Makarios. Io sono colui che avete scelto come vostro leader… Non sono morto, come la “giunta” di Atene e i suoi rappresentanti qui volevano. Sono vivo. E sono con voi, per combattere e portare la bandiera nella nostra lotta comune. Il golpe della giunta è fallito…»
La notizia della morte di Makarios era arrivata anche agli statunitensi e per un paio di giorni ci fu incertezza sul suo destino. I suoi ex nemici, i britannici, infatti avevano organizzato la sua esfiltrazione e il suo nuovo esilio a Malta nel più assoluto segreto. La reazione della diplomazia Usa, guidata da Kissinger, al golpe fu piuttosto tiepida. Le priorità di Washington erano chiare: si doveva evitare a ogni costo l’intervento sovietico, si doveva fermare l’internazionalizzazione e tenere calmi i sostenitori di Makarios. La crisi cipriota venne affrontata da Kissinger dialogando con Waldheim, segretario dell’ONU, turchi e greci.
Le ragioni greche dietro al colpo di mano furono efficacemente spiegate dal capo della giunta ellenica, il generale Ioannidis. Nel report di un incontro tra il militare e un emissario statunitense, si legge chiaramente la versione di Atene:
«A questo punto l’emissario intervenne a bruciapelo e disse a Ioannides (sic) che, con il colpo di stato avvenuto solo ventiquattr’ore dopo aver riferito su un possibile rovesciamento di Makarios, restava molto difficile da credere che non fosse stato coinvolto nel golpe. Il generale è nuovamente esploso agitando le braccia. Ha rovesciato lo stesso tavolo, ha rotto un secondo bicchiere e, tra oscenità, ha dichiarato di non aver pianificato e organizzato il colpo di stato. Il piano iniziale era dei nazionalisti greco-ciprioti… Il generale ha dichiarato di non poter accettare 85.000 rifugiati greco-ciprioti. Ciò, unito agli sforzi anti-regime di Makarios, lo ha portato a decidere di assistere i nazionalisti. Il generale ha affermato che se Makarios fosse riuscito a cacciare i greci da Cipro, cosa gli avrebbe impedito di pensare di poter cacciare anche la giunta dalla Grecia? Dopo aver deciso di assistere i greco-ciprioti, il generale ha detto di non aver informato la leadership delle forze armate né ad alcun funzionario greco. Ha limitato a far conoscere le sue intenzioni a pochi ufficiali selezionati, il 13/14 luglio; nessun altro lo sapeva e anche dopo gli eventi del 15 luglio solo una manciata di persone era a conoscenza del suo ruolo. Ioannides (sic) giustificò questa azione affermando che se avesse informato più persone, queste avrebbero sollevato suggerimenti, consigli, alternative e possibili problemi. Ha aggiunto di aver agito d’impulso».
Le principali preoccupazioni americane erano evitare un colpo di mano dei comunisti ciprioti e bloccare l’invasione turca che stava per essere lanciata. Kissinger non era favorevole al ritorno di Makarios ed era disinteressato anche sul destino di Ioannidis:
«Non sono preoccupato di Ioannidis. Se cade, va bene. Non mi preoccupa. Lasciamolo cadere a causa della sua incompetenza. Liberarsi di Ioannidis non è una preoccupazione maggiore rispetto a tenere Ioannidis; non è un fattore. Prevenire una guerra greco-turca e un cambiamento nel bilanciamento del potere sono fattori. Non penso Ioannidis sopravviverà a lungo in ogni caso».

19 agosto 1974, Nicosia. Una immagine dei tumulti contro la politica americana su Cipro (fonte: Associated Press)
Dopo appena cinque giorni dal golpe contro Makarios, la Turchia invase la parte nord di Cipro. Il timore di una risposta greca venne spazzato via dopo pochi giorni viste le indecisioni della giunta militare, preambolo della sua caduta. Washington spingeva per un immediato cessate il fuoco così da iniziare le negoziazioni con celerità. Affinché ciò potesse accadere, si doveva cercare qualcuno che sostituisse Sampson. Kissinger individuava alcune figure:
«La nostra politica è liberarsi di Sampson. Chi lo sostituirà non è una preoccupazione per noi. L’unica questione è che sia Makarios o Clerides o qualcun altro che arrivi».
Il 23 luglio 1974, mentre gli scontri a Cipro proseguivano, il regime militare greco collassò definitivamente. Gran Bretagna e Stati Uniti videro l’invasione turca dell’isola come una sorta di esperimento militare:
«Ambasciatore Ramsbotham: Ero preoccupato per la performance turca a Cipro perché è sembrato che non fossero capaci di utilizzare bene le armi moderne, e penso che ciò abbia delle conseguenze infelici per il fronte meridionale della NATO. Hanno anche fallito a prendere l’aeroporto di Nicosia».
Londra e Washington si accordarono anche sul nuovo presidente di Cipro. Si decise di puntare, in un primo momento, su Clerides e non Makarios. Nel frattempo, il ritorno della democrazia in Grecia, personificata da un redivivo Karamanlis, fu accolto positivamente, anche in relazione alla situazione cipriota. Makarios, che continuava a trattenere rapporti con gli esponenti statunitensi, voleva tornare sull’isola ma gli fu impedito.
Qualche settimana dopo l’invasione, Istanbul decise di far partire una seconda operazione militare. L’obiettivo era un ulteriore guadagno territoriale in vista dei negoziati di pace. Mentre l’ordine pubblico cipriota si deteriorava enormemente, c’era stata perfino la morte dell’ambasciatore statunitense Rodger Davis, ucciso il 19 agosto 1974 in un conflitto a fuoco iniziato durante una delle molte manifestazioni antiamericane, la posizione della comunità internazionale cominciò a cambiare a favore della nuova Grecia democratica. Per questa ragione, la Turchia giudicò più che soddisfacente l’aver ottenuto il 38% del territorio cipriota. I colloqui di pace iniziarono e si conclusero con Istanbul che instaurò un governo fantoccio in una porzione dell’isola.
La seconda invasione turca di Cipro terminò il 18 agosto 1974. Makarios, tornato sull’isola, divenne presidente per un altro mandato nel dicembre dello stesso anno. Morì il 3 agosto 1977. Gli succedette il suo ex delfino, Spyros Kyprianou, che tempo prima era stato esautorato per compiacere la giunta militare ellenica. Dall’altra parte, la Turchia istituzionalizzò la sua presenza sull’isola. Dal 1983, infatti, si parla di Cipro del Nord.
Ciò che si nota in questa vicenda è la presenza di personaggi molto particolari come Makarios e Grivas, capaci di barcamenarsi tra difficoltà e interessi diversi con grande abilità. L’etnarca, soprattutto, è una figura affascinante. Personalità religiosa vicina ai comunisti dell’AKEL, sostenitore in un primo momento dell’enosis e poi campione dell’indipendenza di Cipro, Makarios fu mandato in esilio per due volte ma fu l’assoluto protagonista della vita politica isolana. Il suo fine ultimo — il superamento delle divisioni etniche in una Cipro unificata — tuttavia non fu raggiunto, soprattutto a causa di condizionamenti esterni.
Quest’ultimo tema è assolutamente decisivo. La presenza soffocante di Turchia e Grecia non ha permesso la creazione di un’identità nazionale cipriota, bloccata anche dall’influenza di Stati Uniti e Gran Bretagna. Londra, tuttora in possesso di due basi militari, ha sempre rappresentato un ostacolo alla piena indipendenza cipriota secondo una continuità strategica che rappresenta una delle costanti della politica estera britannica. In una prospettiva più legata agli interessi angloamericani sull’isola, tutto questo emerge d’altronde chiaramente nei documenti provenienti dal Dipartimento di Stato.
Anche così si spiega il fatto che la divisione cipriota sia tuttora una questione irrisolta.